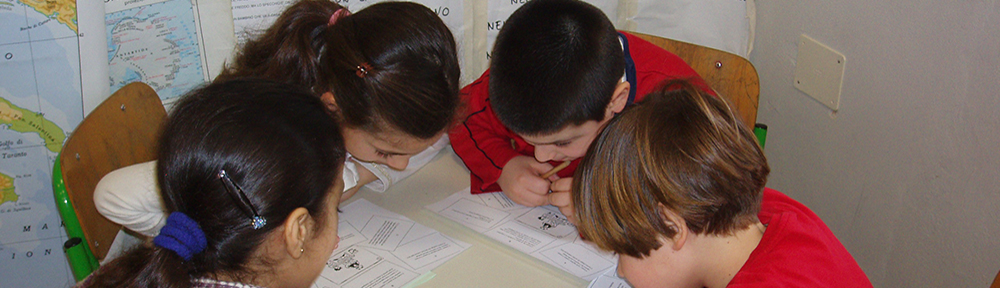Redazione del testo: Gabriele Pallotti
I testi descrittivi sono quelli in cui predomina una rappresentazione di uno spazio, che può contenere oggetti o anche personaggi che compiono azioni. In quest’ultimo caso, non è facile tracciare una demarcazione netta rispetto ai testi narrativi, ma in un testo a dominanza descrittiva non si trova una vera e propria trama, un filo che leghi degli avvenimenti in una sequenza coerente, ma solo la rappresentazione di chi fa che cosa.
Un testo descrittivo contiene una serie di informazioni su oggetti o personaggi, per ciascuno dei quali possono venire espresse alcune proprietà: l’aspetto, l’attività che sta svolgendo, la collocazione rispetto ad altri referenti. Non è assolutamente possibile elencare tutti i dettagli di una situazione, e ogni descrizione è pertanto altamente selettiva: questa scelta dipende essenzialmente dalle necessità comunicative. Dunque, se devo spiegare a qualcuno come raggiungere casa mia, dirò che è accanto a un distributore di benzina, ma non descriverò minuziosamente quest’ultimo, con i suoi colori, il numero di pompe, l’ampiezza del piazzale e così via. Insomma, una descrizione potrà essere più o meno vivida e dettagliata, ma non sarà mai esaustiva, e in ogni caso non è detto che una maggiore lunghezza sia indice di migliore qualità: la descrizione deve essere funzionale, nè scarna né prolissa.
Per produrre un testo narrativo esiste una sorta di scaletta ‘naturale’ dei contenuti, che coincide con l’ordine cronologico degli eventi: si narra prima ciò che è accaduto prima e dopo ciò che è accaduto dopo. È un modo perfettamente adeguato di raccontare una storia, e intrecci più complicati possono essere dettati da esigenze stilistiche o effetti retorici, ma non sono indispensabili. Non esiste invece un modo ‘naturale’ di esporre i contenuti di una descrizione, perché essi possono essere raggruppati secondo diversi criteri: concettuali, ad esempio elecando prima tutte le cose poi tutti gli esseri animati; percettivi, menzionando prima gli aspetti più salienti e poi i dettagli; spaziali, procedendo dall’alto in basso, o in senso orario, o dal centro alla periferia o viceversa.
Normalmente, per descrivere le entità nello spazio esse vengono collocate rispetto a uno sfondo o ad altre entità: l’entità messa in primo piano viene detta figura, o tema, quella rispetto a cui viene collocata è detta sfondo o relatum. Ma al di là di questo principio generalissimo, ce ne sono altri più specifici che possono essere seguiti per organizzare una descrizione spaziale:
– L’entità può essere collocata rispetto al quadro globale (cioè la figura nel suo insieme), dicendo cose come al centro ci sono dei palazzi; nell’angolo in basso c’è una fontana, oppure rispetto ad altre entità precedentemente mezionate, in un quadro additivo che si forma man mano, come in sotto i palazzi si vedono delle panchine, accanto alle panchine ci sono dei bambini che giocano.
– Il quadro additivo, a sua volta, può essere prodotto o esprimendo relazioni generiche di vicinanza o inclusione, dette topologiche (vicino all’albero; nella piazza; in classe) oppure relazioni più specifiche, dette proiettive, che fanno riferimento ad assi di coordinate spaziali (a destra della bicicletta; sotto l’albero; sopra la cattedra).
– Infine, la descrizione può seguire diverse prospettive. In una prospettiva fissa, ci si immagina di vedere tutta la scena dall’esterno e si segue un ordine che può essere la divisione in quadranti della scena (alto/basso, sinistra/destra, centro/periferia). Questa strategia viene usata tipicamente per descrivere immagini bidimensionali, come quadri e fotografie. Quando invece si descrivono ambienti più complessi, come un appartamento o un edificio, spesso viene seguita una prospettiva mobile, in cui si accompagna l’interlocutore in una specie di tour virtuale, dicendo cose come Entrando sulla destra vedi la cucina; proseguendo per il corridoio a sinistra ci sono le stanze da letto, mentre in fondo c’è il bagno; entrando in bagno, a destra trovi la doccia. È tipico di questa modalità descrittiva l’uso della seconda persona e di verbi di movimento, come entrare, proseguire, continuare. Spesso la prospettiva mobile viene impiegata anche nelle descrizioni di immagini bidimensionali, in quello che si chiama il giro dello sguardo: lo sguardo si muove sull’immagine seguendo un percorso, che non è necessariamente sistematico secondo gli assi cartesiani, ma può andare da un oggetto o spazio all’altro con complesse relazioni di continuità. Con questa modalità si trova più frequentemente la terza persona e l’uso di verbi stativi, come in in alto ci sono degli alberi, accanto c’è una fontana dietro alla quale si vedono dei bambini che giocano; poi ancora sotto ci sono delle case.
Dopo avere discusso le descrizioni di entità relativamente fisse su uno spazio statico, possiamo brevemente accennare alla descrizione di scene che contengono azioni. Il problema, in questi casi, è esprimere la simultaneità tra diversi eventi in una sequenza lineare di frasi. Anche in questo caso, non esiste un principio organizzativo ‘naturale’, basilare, ma occorre compiere delle scelte, decidendo dove iniziare e come proseguire. Si possono seguire i criteri spaziali usati per descrivere gli oggetti, oppure gerarchizzare le azioni, trattandone alcune come principali e altre come accessorie: ad esempio, nel descrivere una classe piuttosto vivace, posso tenere come filo conduttore le azioni dell’insegnante e collocare rispetto a queste le azioni degli alunni, ma posso anche scegliere la prospettiva di un particolare alunno, e così via.
Come si vede, esistono molti modi di produrre una descrizione e nella comunicazione orale non ci si preoccupa tanto di essere sistematici: i diversi referenti e le loro proprietà vengono evocati man mano che si presentano allo sguardo o alla coscienza. I testi scritti consentono una maggiore pianificazione e le descrizioni dunque seguono ordini più espliciti: si pensi alla famosa ‘zoomata’ sul lago di Como che apre i Promessi sposi, o a tutte le forme di descrizione rigidamente codificate all’interno di moduli (come quelli anagrafici) o di protocolli scientifici (come le anamnesi mediche o le descrizioni di esperienze di laboratorio).
Lo sviluppo delle competenze descrittive
La percezione dello spazio è una funzione cognitiva basilare, che emerge prestissimo nello sviluppo umano e che già a pochi anni è pienamente consolidata. La capacità di descrivere lo spazio, invece, cresce molto lentamente e ancora a dieci anni i bambini mostrano significative differenze rispetto agli adulti nella resa delle relazioni spaziali, sia nei racconti che nelle descrizioni di immagini statiche.
Un primo ordine di difficoltà ha a che fare con il patrimonio lessicale: per fornire una buona descrizione servono parole appropriate, ed è noto che il lessico si amplia notevolmente fino a tutta l’adolescenza, specie in chi segue percorsi scolastici.
I bambini e i ragazzi incontrano però difficoltà anche nel descrivere situazioni e oggetti familiari, per cui dispongono di tutte le parole necessarie: ciò che manca in questi casi è una vera e propria competenza descrittiva, come capacità di costruire un certo tipo di discorso con le sue specificità funzionali. Vediamo ora come si sviluppa questa competenza nei bambini di 4, 7 e 10 anni, basandoci sugli studi di Giuliano et al (2003) e Hendriks et al (2004) che hanno chiesto a bambini italiani, polacchi, inglesi e francesi e ad apprendenti di seconda lingua di descrivere l’immagine di una piazza con molti oggetti e personaggi.
A 4 anni i bambini producono semplici liste di oggetti, che non vengono posizionati in alcun modo nello spazio, ma costituiscono semplici apparizioni, come in Allora una casa. Poi una strada. Delle macchine. Una bicicletta. Dei signori. Un giornale. Queste liste non sono totalmente disorganizzate, ma seguono spesso dei semplici principi di salienza percettiva: ad esempio vengono nominate prima le cose grandi, o di primo piano, o nella parte centrale della figura. A volte i nomi vengono specificati meglio con qualche modificatore, come in una bici con un signore o una signora in bicicletta, o raramente con sintagmi preposizionali localizzanti, come in c’è una bicicletta sull’albero. Queste localizzazioni sono quasi esclusivamente topologiche, cioè del tipo ‘vicino a’ o ‘in’. Quasi assente la localizzazione generale esplicita, cioè che fa riferimento all’immagine nella sua interezza, indicando che l’oggetto vi si trova in alto, in basso o o al centro. Se si chiede di aggiungere dettagli, i bambini piccoli descrivono meglio gli oggetti (ad es il colore o l’aspetto), ma quasi mai la loro collocazione spaziale.
Anche a 7 anni i bambini stentano a riferirsi all’immagine nel suo insieme, con localizzazioni degli oggetti rispetto al quadro globale. Crescono invece notevolmente le localizzazioni locali, cioè dei referenti gli uni rispetto agli altri, e se si chiedono precisazioni, esse ora riguardano anche la posizione degli oggetti. Aumenta la varietà di preposizioni per esprimere relazioni (ad esempio tra), ma esse continuano a essere principalmente di tipo topologico, generico (vicino, accanto) più che proiettivo (davanti, dietro, sopra, sotto) e queste ultime raramente sull’asse laterale (a destra/sinistra). Mentre gli adulti non hanno dubbi nello scegliere il relatum (o sfondo) tra gli oggetti relativamente grandi e fissi, rispetto a cui localizzare figure più piccole e mobili, spesso i bambini di questa età seguono la strategie opposta, costruendo enunciati come c’é un albero vicino alle bambine che giocano, che suona quanto meno curioso.
Ancora a 10 anni i bambini non collocano sistematicamente i referenti rispetto al quadro globale dell’immagine, ma continuano a seguire la strategia del menzionarne uno e poi collocare gli altri rispetto a quello, senza che l’interlocutore possa capire dove tutto ciò si trovi rispetto alla figura nel suo insieme. Si veda ad esempio questo inizio di descrizione: Allora vedo una + delle case. Poi mò passiamo alla strada e alla gente e a tutto il resto. Aumentano le relazioni proiettive tra referenti, che sono principalmente sull’asse verticale (sopra/sotto) e meno sugli assi sagittale (dietro, davanti, oltre, di fronte) e laterale (a destra/sinistra). Le relazioni proiettive laterali richiedono di tener conto di tre punti di riferimento – 1) il tema, 2) il relatum e 3) il parlante o l’ascoltatore – come in la fontana (1) è a destra (mia/tua) (3) della piazza (2), e si sviluppano pienamente solo in età adulta. Il significativo passo in avanti che si riscontra a 10 anni è la costruzione di testi descrittivi che mostrano sempre più coesione interna e assomigliano sempre meno alle liste sparse dei bambini di 4 anni: troviamo espressioni spazio-temporali comesempre/ancora, additive come ancora/altro e l’avverbio avversativo invece, che contribuiscono a dare l’impressione di un testo in cui le diverse parti si tengono tra loro in modo più stretto, con enunciati come E poi vi è un altro palazzo sempre vicino alle persone.
Questa evoluzione ha a che fare essenzialmente con lo sviluppo cognitivo e comunicativo, e solo in parte con quello linguistico. Ciò è dimostrato dal confronto tra bambini e apprendenti adulti di una L2. Anche i livelli principianti, che dispongono certamente di mezzi linguistici più rudimentali di quelli dei bambini nativi, non hanno difficoltà a collocare gli oggetti rispetto al quadro globale della figura descritta, o ad esprimere relazioni proiettive di vario genere, tra cui quelle laterali, che abbiamo visto invece causare problemi fino a 10 anni.
Per quanto riguarda l’espressione della simultaneità tra azioni, anche questa presenta uno sviluppo lento durante tutta l’infanzia e la preadolescenza. Prima dei 7 anni i bambini non esprimono quasi mai relazioni di contemporaneità, ma le rendono come se si trattasse di azioni successive con connettivi quali e, poi, allora. A 8 anni (e comunque dopo avere svolto un percorso didattico sulla descrizione di azioni simultanee) troviamo espressioni come Filippo sta: ## sta svolgendo dei co:mpiti. mentre gli altri: finiscono la merenda oppure Molti bambini stanno parlando: con la Bleonita? e lei nel frattempo: sta cercando di da(h)rgli un po’ della sua merenda. Tra i 7 e i 10 anni crescono di numero anche le subordinate temporali introdotte da quando, come in Il bambino stava per annegare quando il cane vide una scala oppure Quando la maestra entra# tutti si alzano e gli dicono buongiorno.