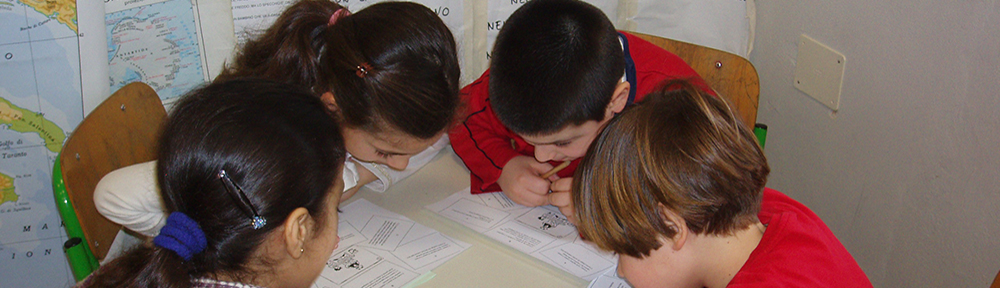Sulla base del modello induttivo e non prescrittivo di educazione linguistica che si intende promuovere, si elencano alcuni principi che possono guidare l’insegnante nella programmazione e conduzione delle attività didattiche: – non utilizzare in classe l’etichetta metalinguistica preposizione, se non (eventualmente) al termine del percorso, a conclusione di un processo di scoperta attiva di questa classe di parole da parte degli alunni; – non impostare l’insegnamento delle preposizioni sulla distinzione scolastica tradizionale in preposizioni semplici/articolate (apprendimento mnemonico della sequenza: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra; riflessione esplicita sulla struttura composta delle preposizioni articolate: preposizione semplice + articolo determinativo). L’esito da scongiurare è che gli allievi arrivino a ritenere che la categoria delle preposizioni si riduce alle poche parole che hanno appreso meccanicamente, senza interrogarsi sul che cosa rende le preposizioni una classe; – non impostare l’insegnamento delle preposizioni nemmeno sulla loro articolazione scientifica in preposizioni proprie/improprie/locuzioni preposizionali. Il rischio, muovendo dal metalinguaggio alla lingua, anziché viceversa, è che, si ribadisce, gli allievi abdichino ad applicare l’intelligenza alla lingua; – proporre agli allievi un lavoro sulle preposizioni linguisticamente e cognitivamente rilevante, che li stimoli a (ri)costruire in maniera induttiva, creativa e non lineare questa classe di parole e, quindi, a riconoscerne tra gli elementi costitutivi anche preposizioni che generalmente non sono annoverate nelle grammatiche scolastiche (ad esempio, insieme a, senza, dentro a, verso); – come suggeriscono gli studi acquisizionali, insistere sulle preposizioni che indicano relazioni spazio-temporali (ad esempio, dopo di, prima di, davanti a, vicino a, dietro a, sotto a, sopra a, dentro a, in/nel/nello/nella/nei/negli/nelle), sottolineandone l’uso con, ad esempio, l’innalzamento della voce e la gestualità; – come suggeriscono gli studi acquisizionali, privilegiare, in una fase iniziale, strutture del tipo Prep. + SN (ad esempio, nell’astuccio, sopra al mobile) e, solo in stadi più avanzati, proporre strutture nelle quali la preposizione regge un complemento altro dal sintagma nominale (ad esempio, spero di riuscire a vincere; non è accaduto nulla di speciale); – come suggeriscono gli studi acquisizionali, presentare ogni preposizione prima nei propri usi prototipici (ad esempio, di = appartenenza; con = compagnia), quindi in quelli periferici o nei quali la scelta è soggetta a variabilità idiosincratica, cioè è maggiormente libera (ad esempio, un tavolo in/di legno).Se gli allievi devono poter lavorare sulle preposizioni in modo il più possibile spontaneo, quasi ingenuo, non così devono agire gli insegnanti, i quali sono invitati, prima e durante il percorso didattico, ad approfondire le proprie conoscenze in merito a questa categoria di parole, sia dal punto di vista grammaticale che acquisizionale. Poiché le grammatiche scolastiche sono spesso riduttive (e, comunque, privilegiano un approccio normativo e puramente classificatorio dei fatti linguistici, dei quali non si preoccupano di spiegare in modo critico e problematizzante il funzionamento), si consiglia agli insegnanti di procurarsi buone grammatiche di consultazione (vedi Bibliografia e risorse utili). Per gli insegnanti, può anche essere molto utile documentarsi rispetto agli studi acquisizionali: infatti, come mettono in luce le ricerche, gli apprendenti di italiano L2 procedono secondo sequenze abbastanza regolari e prevedibili nell’acquisizione delle preposizioni.Su entrambi gli aspetti si possono consultare, come approfondimento, i seguenti testi allegati:Descrivere le preposizioni in italiano L’acquisizione delle preposizioni in italiano L2
Allegati
Allegato 1 descrizione preposizioni
Allegato 2 acquisizione preposizioni itaL2